La ragione principale per cui i classici non vengono letti volentieri, soprattutto dagli studenti (sigh), è che sono semplicemente passati.
Vengono imposti, affrontati sempre alla stessa maniera, sono distanti, “Prof la prego, basta con questo Dante!”
Non sempre è possibile, okay, ma se ci fosse un modo per attualizzarli? Si possono rendere questi autori uomini e donne del nostro tempo?
Uno degli scopi del mio blog in realtà è proprio avvicinare il passato al presente. No, non sto parlando di quella specie di screenshot (molto boomer tra l’altro) di chat immaginarie tra scrittori morti, ma di qualcosa di più significativo.
Quindi vi presento due amici che, per un tratto almeno, hanno viaggiato in parallelo.
Il primo è Giacomo Leopardi, lo conoscete, giusto? È quasi famoso quanto Madonna. Nel 1828 scrive il celebre componimento “A Silvia”, sentito, strasentito, maturato in seguito alla morte della sua vicina di casa, sostanzialmente, avvenuta dieci anni prima.
Il secondo è Matteo B. Bianchi, autore di “La vita di chi resta”, romanzo pubblicato un paio d’anni fa.
Detta così, sembra che io abbia pescato due persone a caso obbligandole a diventare compagni di banco. I miei studenti, però, se solo mi ascoltassero ogni tanto (faccina con sorriso imbarazzato e goccia lungo la tempia destra), scoprirebbero con piacere che Leopardi potrebbe già essere il loro compagno di banco, perché lui è dappertutto (no, non farò la battuta del prezzemolo, scordatevelo).
Cominciamo dal principio.
S. è il compagno di Matteo. Va be’, al momento in cui risalgono i fatti in realtà non lo è più, ma, come dice l’autore stesso: “S. era stato il mio quotidiano per oltre sette anni. Così a lungo che mi era impossibile ora pensare che non potessi sentirlo, chiamarlo, toccarlo, litigarci, parlare. Essere divisi da qualche settimana non cambiava nulla”.
Silvia non è mai stata la fidanzata di Leopardi, anzi non siamo neanche sicuri che il poeta fosse innamorato di lei. Anche in questo caso, però, lo stato civile non è così rilevante: a lui infatti bastava guardarla ogni giorno dalla finestra e, in un certo senso, essere cresciuto insieme a lei, nella distanza tra due palazzi.
S. si suicida senza spiegazione, se non un disagio simile a tanti altri, nella casa in cui lui e Matteo hanno vissuto insieme per tanto tempo.
Silvia muore improvvisamente di tisi, a ventiquattro anni, ingiustamente, e ancora bellissima.
Leopardi e Bianchi sono scrittori, ma entrambi ci mettono un po’ per scrivere di S. e Silvia, perché un dolore del genere merita un certo riguardo, il tempo di depositarsi su tutto per poi ritirarsi lentamente, come fanno le mareggiate. Ma anche perché, come ho spiegato nel pezzo della volta scorsa, a volte quando stai troppo male non hai la forza per buttare giù neanche una parola.
I due autori, oltre a una perdita che fa malissimo, hanno in comune il fatto di non parlare tanto di ciò che hanno perduto, piuttosto di com’è la vita di chi resta.
“Cerco conforto nella letteratura […] Non c’è molto sul tema suicidio. In molti romanzi compaiono personaggi suicidi, certo. Ma una narrativa specifica sul questo tema? […] Trovo solo materiale sulle vittime, non sui superstiti. Ma io sono uno di loro, è con loro che vorrei un confronto, un aiuto. Perché nessuno se ne occupa? Perché ignorano il dolore di chi resta?”, è l’appello di Matteo.
Per Giacomo, invece, quella morte è un pensiero intrusivo a proposito di ciò che ha smarrito a sua volta: “Anche peria fra poco | la speranza mia dolce: agli anni miei | anche negaro i fati | la giovanezza. Ahi come, | come passata sei, | cara compagna dell’età mia nova, | mia lacrimata speme”.
Leopardi ci fa sapere come sia difficile sopravvivere a qualcuno e quanto sia naturale paragonare il trauma di una vita spezzata, dei sogni che fuggono via, alla disillusione di uno che, una volta diventato grande, si accorge di non aver avuto dalla vita quello che sperava.
Ovviamente chi non c’è più viene ricordato con commozione, Silvia “Quando beltà splendea | negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, | e tu, lieta e pensosa, il limitare | di gioventù salivi”. S. invece, “I capelli rasati, gli occhi chiari, gli avambracci che spuntavano dalle maniche arrotolate della sua t-shirt bianca finivano sempre per attirare qualcuno. […] Lui non ostentava niente. La gente trovava scuse qualsiasi per parlargli, hai da accendere, sai che ore sono, le solite banalità.”
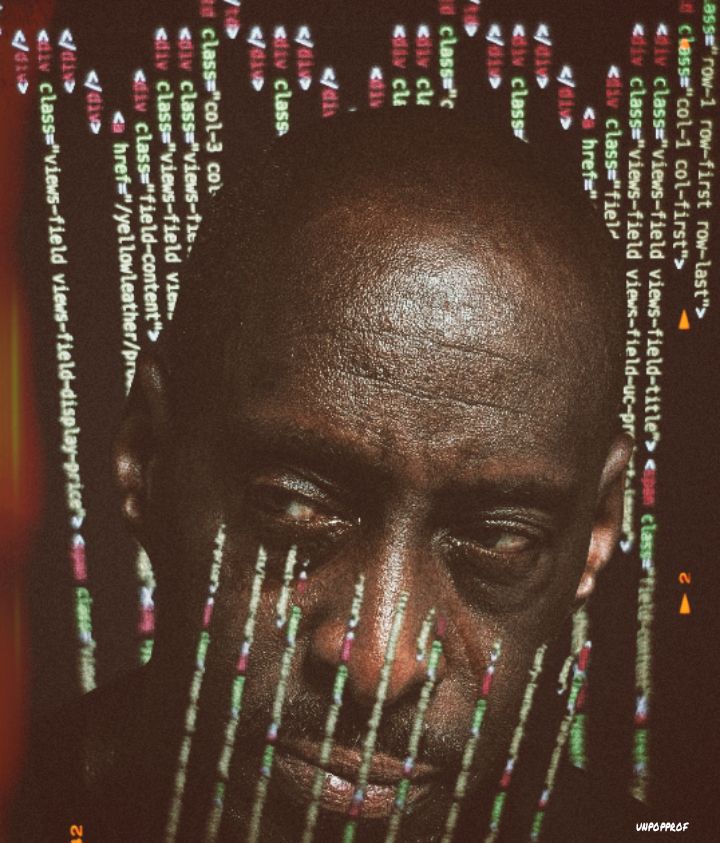
Matteo e Giacomo, a distanza di secoli l’uno dall’altro, continuano a porsi la stessa domanda, come hanno fatto a finire così, semimorti a loro volta, all’ombra di qualcuno che non c’è più.
“Quando sovviemmi di cotanta speme, | un affetto mi preme | acerbo e sconsolato, | tornami a doler di mia sventura.”
“Credete di vedermi, credete di parlare con me, ma vi sto illudendo. Andate pure avanti con le vostre cose. Le banalità del mondo non mi riguardano più, ora che ho conosciuto la vera oscurità. C’è una forma di arroganza nella sofferenza pura”
E sì, arroganti forse lo sono entrambi, se proprio vogliamo dirlo, che pensano a se stessi quando qualcun altro ha avuto un destino ben peggiore. Ma non è forse vero che pensare alla propria mascherina dell’ossigeno è l’unico modo per salvarsi?
Per nessuno dei due scrittori, poi, c’è sollievo nella fede. Leopardi è ateo fino al midollo: ve l’ho già detto, sui libri di testo è associato al romanticismo (lo stesso periodo di Manzoni che con Dio costituisce un duetto che neanche Paola e Chiara), ma se l’aveste chiesto a lui, vi avrebbe risposto che era un illuminista: tanta ragione, poco spirito. A volte è proprio vero che bisogna scegliere tra le due cose.
Bianchi invece ci rivela: “Affronto questo dramma senza Dio. […] Ho smesso di credere a un certo punto. Non so dire quando […] Ho capito che la convinzione che chiamano fede in me non era presente. Ne ho preso atto. La tragedia non mi ha avvicinato a Dio, il dolore non mi ha reso ipocrita. […] Non avevo un Dio da invocare, non avevo neanche un Dio a cui indirizzare la tutta la mia rabbia. Non so se sia un guadagno o una perdita, in nessuno dei due casi.”
Anche se ora lo state pensando, no, non ho fatto grandi spoiler, anzi, vi consiglio caldamente di leggere entrambi i testi, magari uno dopo l’altro, se proprio volete darmi retta.
La morte è ciò lega tutti noi mortali, dalle origini del mondo fino ad oggi, ma è un concetto così assurdo, così al di là, che diventa inesprimibile: perfino Dante, quando si trova ad avere a che fare con i regni ultraterreni, ammette che a volte non trova le parole per descrivere ciò che sente e vede (e lui era Dante, cazzo).
Ciò che lega i due autori di cui ho parlato – e Dante e tutti noi – è lo sforzo di raccontare proprio dell’argomento per cui le parole sono insufficienti, del segreto a cui chiunque vorrebbe avere accesso.
E allora gli scrittori polverosi non sono proprio così fuori moda, perché alla fine sono ossessionati dalle stesse questioni del nostro tempo e ne parlano in modo sempre nuovo, sempre attuale. Poi, per una volta, e contrariamente alla tendenza diffusa, oltre a celebrare Silvia e S. che se ne sono andati decisamente troppo presto, vorrei dedicare questo pezzo a chi, con coraggio invece, ha sopportato l’onere di restare, ossia Giacomo e Matteo. Questo è per voi.

Lascia un commento